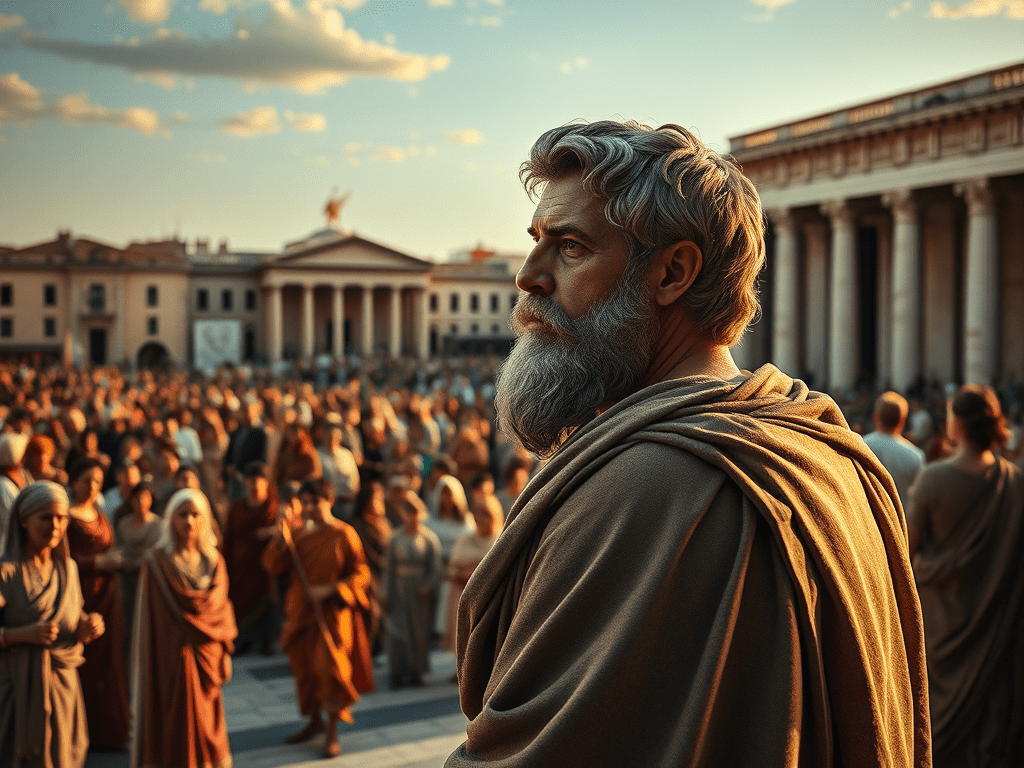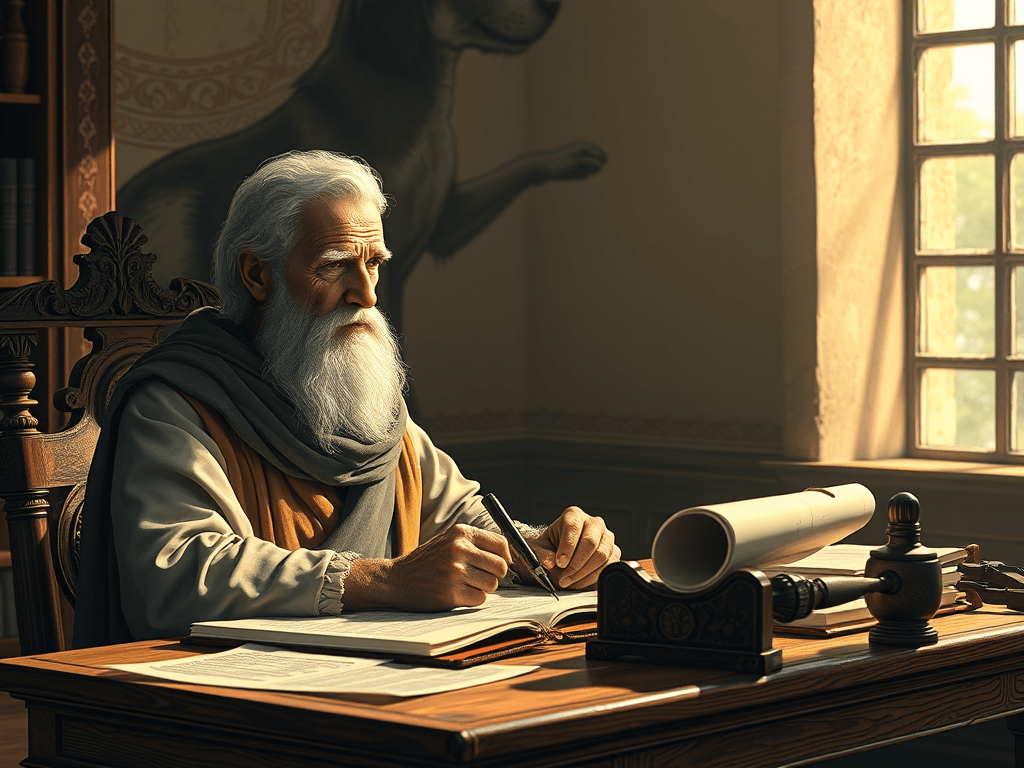
283 Crantore scrive una lettera di consolazione
-Hai sentito la storia di Crantore?
-Chi? Il filosofo dell’Accademia, autore del Sulla tristezza? Dicono sia un tipo singolare.
-Infatti, quello che ti racconto lo conferma. Pare che abbia scritto una lettera di consolazione a una persona colpita da un lutto.
-Be’, non è cosa strana, tanti filosofi lo fanno, per lenire le ferite dell’esistenza.
-No, aspetta, il caso è diverso. Si tratta di una persona afflitta per aver perso il suo cane.
-Coi tempi che corrono non mi stupisco più di nulla. Ma amare un cane fino a chiedere consolazione mi sembra insulso, e anche sconveniente.
-Il padrone era disperato, come se avesse perso l’amico più caro. Forse per lui era l’unico affetto rimasto.
-Chissà… Ma Crantore ha giustificato in qualche modo il suo gesto? Scrivere una consolazione per un cane non sembra cosa degna di un filosofo.
-Sembra abbia risposto così: “L’anima non misura l’oggetto del suo amore: lo riconosce.”
-Che cosa intendeva?
-Che quello che conta è l’intensità dell’amore, non il suo oggetto.
-Dunque piangere un amico o un cane sarebbe la stessa cosa? Cosa può offrire di tanto prezioso un animale che abbaia e fa la guardia?
-Crantore insiste su questo: non guardare a chi o che cosa suscita l’amore, ma alla risonanza che la perdita produce nell’anima. Quando il legame è profondo, il sentimento non ascolta ragioni.
-Sì, ma per noi ateniesi rimane una cosa ridicola ed esecrabile.
-Forse questo intende Crantore: la consolazione non serve a giudicare ciò che è stato amato, ma a riconoscere ciò che è stato perduto.
-Non sono convinto. Un semplice cane non può meritare tanto elogio.
-E Crantore pare aver aggiunto: “Anche il filosofo rivolge pietà alla creatura che gli ha offerto amicizia senza giudicare“.
-Un cane non ci giudica… bella scoperta. Potrebbe forse farlo?
-Non possiede un intelletto umano, ma può dimostrare in altri modi affetto, fiducia, fedeltà. E così ci insegna una cosa difficile da apprendere: accettare senza giudicare.
-Già, a pensarci… noi uomini siamo sempre pronti a emettere giudizi, ad aggredire al primo errore. Ci facciamo del male usando mille pretesti. Un cane può essere rabbioso, persino pericoloso, ma non è cattivo.
-Ecco, questo è il punto decisivo. Bene e male sono categorie dell’umano, il mondo animale non conosce istanze etiche. In quel senso è innocente.
-Uhm, se il mondo animale è innocente, come dici, come può nascere un’amicizia con noi? L’amicizia richiede scelta, riconoscimento, dialogo.
-È vero: per noi l’amicizia presuppone la parola e la volontà. Ma forse esiste un altro tipo di amicizia che non ha bisogno di discorso, perché lo precede.
-Un’amicizia senza dialogo? Mi sembra impossibile. L’animale non conosce la reciprocità come noi.
-Ma conosce la presenza. E quella è tutto. L’animale accompagna, veglia, protegge. Non chiede e non promette nulla. E proprio per questo non tradisce.
-Vuoi dire che la sua amicizia è più semplice e quindi più pura?
-È priva di concetti e riflessioni. Ma non per questo meno vera. Un cane non discute il senso dell’esistenza, lo vive.
-Rimane una distanza invalicabile: l’animale non può sapere chi siamo.
-Forse proprio per questo ci accoglie senza guardare a nomi, ruoli, meriti o colpe. Ci sta accanto come presenza fedele.
-Quindi l’animale ci conosce senza conoscerci? Sa di noi senza sapere nulla di noi?
-Ci riconosce. E per Crantore altro non serve.
-Allora la perdita di un cane assume un significato più profondo.
-Sì. Perdi qualcuno che ti permetteva di esistere senza difenderti. Qualcuno che ti insegnava a vivere senza dover dibattere, fingere, lottare, dimostrare quanto vali.
-Ora comincio a intravedere il significato della lettera di Crantore. Non è banale come sembrava.
-Forse la sua consolazione non era per la morte di un cane, ma per la scomparsa di una forma rara di amicizia, quella che lascia una ferita silenziosa nell’anima.
21 dicembre 2025