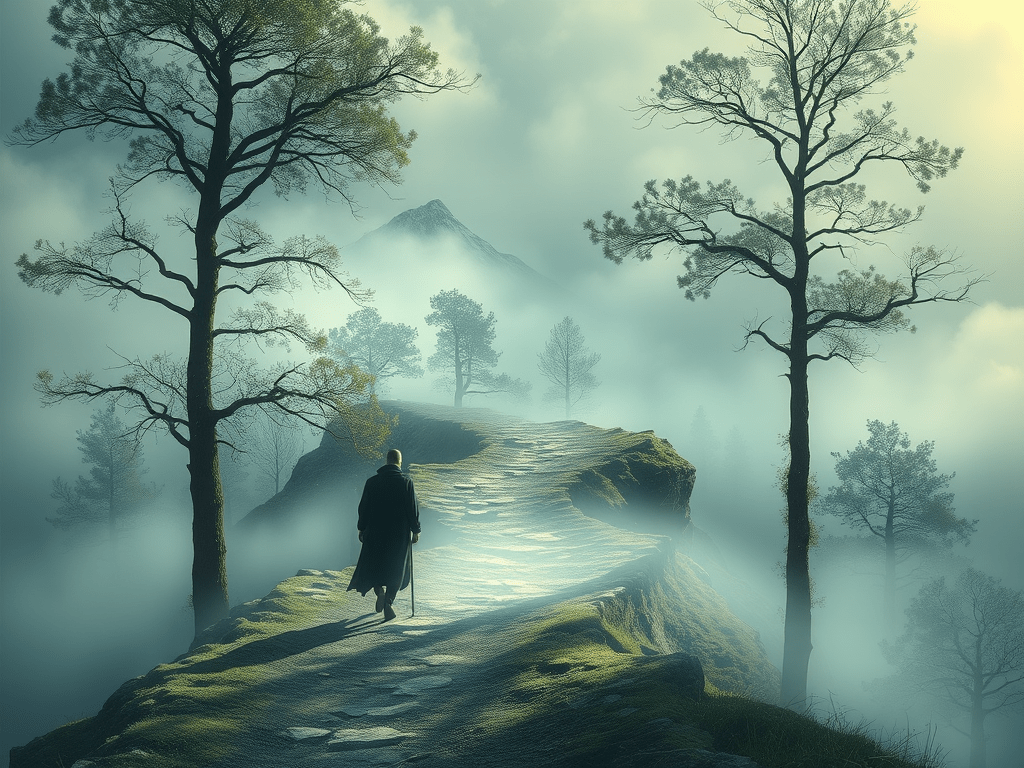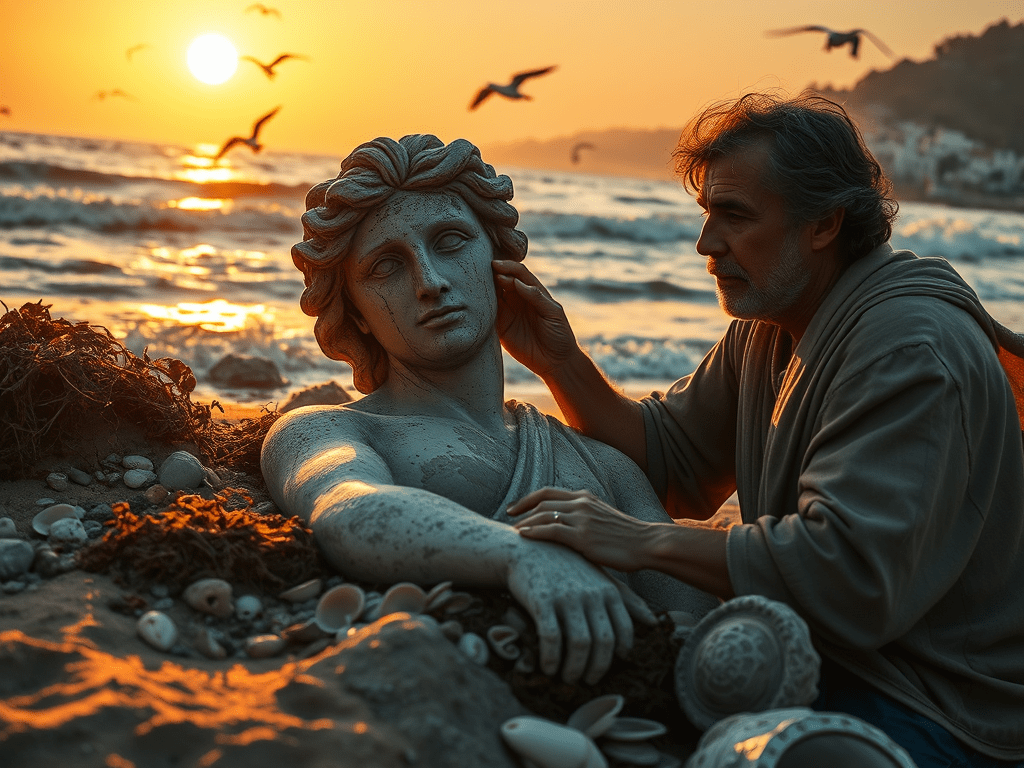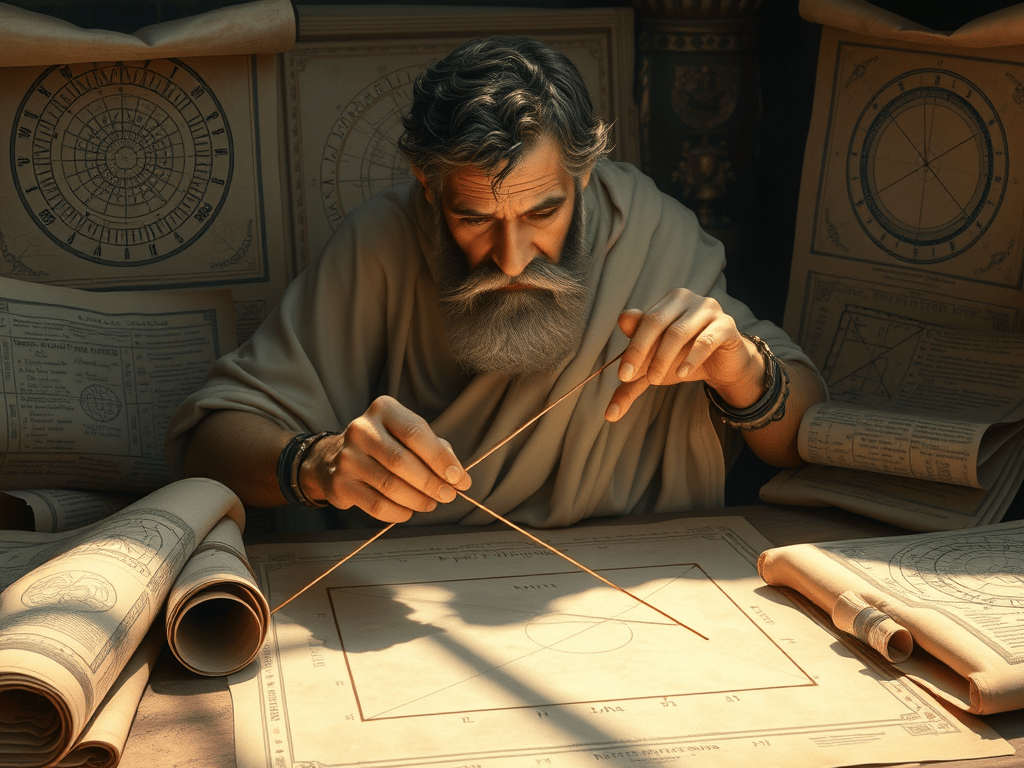272 La farfalla sulla mia ombra
La farfalla
senza saperlo posa
sulla mia ombra
Kikaku (1661–1707)
-La farfalla che si posa sulla mia ombra… Cosa significa?
-È un gesto, un tocco lieve, quasi impercettibile…
-E perché la farfalla lo fa?
-La farfalla non lo fa. Non ne sa nulla. Non sceglie, non decide.
-Che significato ha il suo posarsi se non ne è consapevole?
-In quel gesto inconsapevole, c’è un incontro: tra la sua leggerezza e la mia ombra.
-È un’immagine molto poetica. Parla di grazia?
-Sì, ma anche di una profonda verità.
-Quale verità? Non comprendo…
-Noi cerchiamo di controllare il mondo e dirigere gli eventi. Ma le cose più belle arrivano così, quando nessuno le decide.
-Nessuno le decide?
-Sì, accadono da sole, senza intenzione, come il volo della farfalla.
-Ma se lei non decide nulla, allora chi lo fa?
-Qualcosa di più grande. Kikaku qui non dipinge solo la grazia della natura: descrive l’intelligenza del mondo. C’è un momento in cui la vita sa più di noi. E le cose succedono.
-Però io “so” che le cose accadono, a differenza della farfalla. Sono più intelligente di lei?
-L’intelligenza della farfalla è in sintonia con il Tutto, che pensa e agisce attraverso di lei.
-Però, insisto, non si rende conto di quello che accade…
-La vita ci insegna questo paradosso: non sempre quando “siamo” stiamo vivendo davvero. Un gesto piccolo, inavvertito, ci tocca e ci trasforma. E quanto alla bellezza… il bello non ha bisogno di sapere di esserlo.
-Mmh… È un discorso per me un po’ difficile. Ma perché poi la farfalla si posa su di te?
-La farfalla si posa sulla mia ombra, non su di me.
-C’è un significato anche in questo, immagino…
-L’ombra è la parte che non vedo, che sfugge alla mia volontà. La farfalla si posa sulla mia parte oscura. Ma è il Tutto che lo fa accadere, è il Tutto che lo sceglie.
-Ma perché proprio l’ombra e non, ad esempio, la mano?
-Non sceglie la parte luminosa di noi, ma quella nascosta. In quell’attimo, il mondo compie una riconciliazione. E noi torniamo nel grembo della natura, là dove è la nostra origine.
-Perché è proprio una farfalla a compiere il gesto? È anch’essa un simbolo?
-L’ombra rappresenta ciò che abbiamo lasciato indietro e non ancora integrato. La farfalla, essere di metamorfosi, vi si posa per dire che anche la parte dimenticata merita di essere illuminata. La vita tocca con un alito di bellezza la nostra ombra per ricordarci che anche lì c’è una luce. Nel contatto tra la nostra oscurità e la levità della farfalla si rivela quello che chiamiamo innocenza.
-Certo, una lezione profonda… E a darcela è una semplice farfalla?
-La farfalla non è un essere così semplice come appare. Non sceglie dove andare, è il vento, la luce, il caso a guidarla. Eppure, nel suo volo senza scopo, sembra conoscere il punto esatto in cui la mia oscurità ha bisogno di un tocco di innocenza.
-Forse comincio a capire… La farfalla non cerca un significato: lo crea, col semplice fatto di posarsi. Il gesto è così puro e innocente che diventa una redenzione, una salvezza per chi ne è toccato.
-Sì, sono d’accordo con questa tua bella intuizione. È il Tutto che ci tocca attraverso di lei. Nella spontanea inconsapevolezza c’è una perfezione che nessuna mente umana potrebbe mai inventare, nessun artista potrebbe eguagliare. È la luce che torna a riconoscere l’ombra come parte di sé. E in quel riconoscimento, ogni colpa si scioglie. Kikaku non descrive un fatto naturale, ma un evento cosmico: la luce che arriva sulle ali di una farfalla a riconciliarsi con l’oscurità, con il suo opposto. È un paradosso, ma è davvero così che funziona la vita.
-In conclusione del nostro dialogo mi viene un dubbio… Anche questo nostro parlare “accade”? Siamo anche noi agiti dal Tutto come la farfalla?
-Certo. È sempre il Tutto che fa accadere le cose, anche attraverso di noi. Con la differenza che noi ne siamo consapevoli. Ma dobbiamo stare attenti, c’è sempre il pericolo che la consapevolezza diventi orgoglio. Il rischio di perdere l’innocenza e di separarsi di nuovo dalla nostra origine è sempre in agguato.
-Kikaku ci ricorda con le sue parole poetiche di essere come quella farfalla…
-Mantenere la semplicità, la spontaneità, la purezza, l’innocenza. Lasciarsi vivere dalla Vita stessa. Essere il luogo dove si riconciliano oscurità e luce… Quale insegnamento più grande?
10 novembre 2025